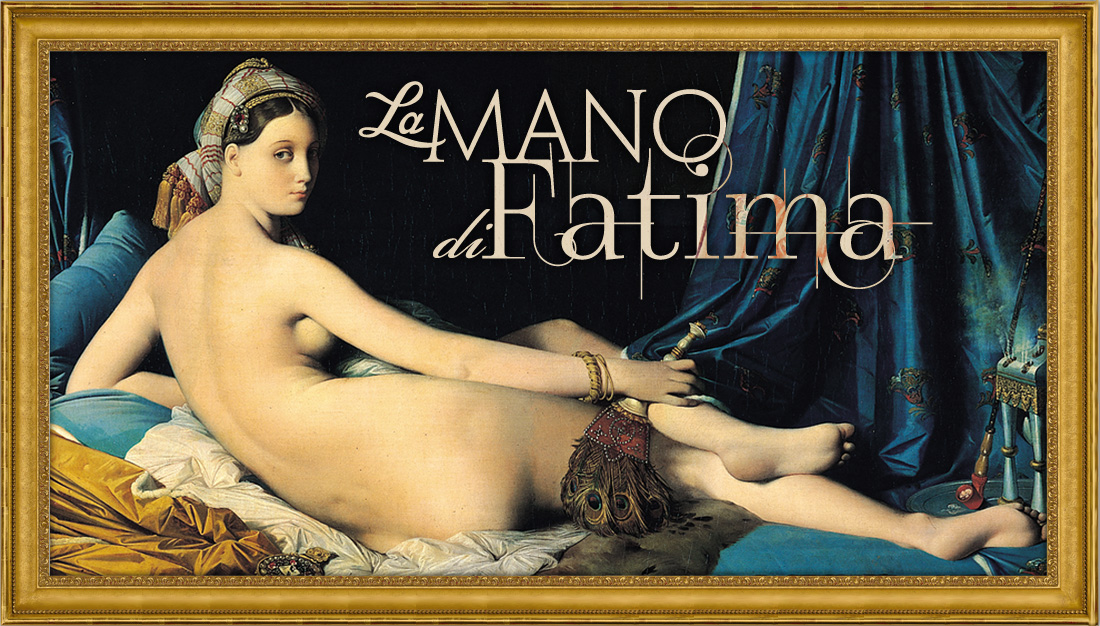La parola araba ǧihād è ormai entrata da molto tempo nel nostro vocabolario; in questi ultimi tempi la sentiamo spesso attraverso telegiornali o talk show, la leggiamo su magazine e libri e ogni volta evoca in noi evidenti e comprensibili sensazioni di paura e anche di confusione, di smarrimento verso qualcosa che non riusciamo a spiegarci fino in fondo, un pericolo che, forse, abbiamo sottovalutato.
La parola araba ǧihād è ormai entrata da molto tempo nel nostro vocabolario; in questi ultimi tempi la sentiamo spesso attraverso telegiornali o talk show, la leggiamo su magazine e libri e ogni volta evoca in noi evidenti e comprensibili sensazioni di paura e anche di confusione, di smarrimento verso qualcosa che non riusciamo a spiegarci fino in fondo, un pericolo che, forse, abbiamo sottovalutato.
Il ǧihād (termine maschile) viene associato esclusivamente a “guerra santa” rafforzando l’aspetto militare e bellicoso del concetto ma, nello stesso tempo, oscurandone la complessità e le sfumature di significato che andrebbero, invece, evidenziate.
Ciò non è affatto strano, se teniamo conto non solo dei recenti casi di cronaca, ma soprattutto della storia delle relazioni tra Europa e Islam.
Eppure, se davvero vogliamo capire cosa sta accadendo oggi nel mondo, avere un’idea il più possibile chiara degli eventi, non possiamo fermarci qui. Dobbiamo leggere, chiedere spiegazioni, fare domande, andare sempre oltre senza pensare di saperne abbastanza. In una parola: informarci. (E questo non vale solo a proposito del ǧihād ).
In questo articolo cerchiamo di capire cos’è e come si è sviluppato il concetto di ǧihād seppur nei limiti di spazio concessi da un blog e, anche per questo, tenendo conto quanto di scritto sopra, ovvero… ci sarà sempre un angolo in cui non abbiamo ancora cercato, ci sarà sempre un libro che non abbiamo ancora letto e che “occhieggia” verso di noi dalla libreria. Ci sarà sempre qualcosa che ci sfugge e una porta che non abbiamo ancora aperto.
Perché indugiare, dunque?
Il significato
Il termine ǧihād, in arabo جهاد , si forma dalla radice ǧ-h-d, attraverso la quale si intende lo sforzo compiuto “sulla via di Dio” (in arabo fī sabīli llāhi; الله سبيل في).
Solo per gli Sciiti è il sesto pilastro dell’Islam, insieme alla professione di fede (shahāda), la preghiera (ṣalāt), l’elemosina (zakāt), il digiuno durante il Ramaḍān (ṣawm) e il pellegrinaggio a La Mecca (ḥaǧǧ) (i cinque pilastri, come sappiamo, riconosciuti sia dai Sunniti che dagli Sciiti).
Fin qui il significato letterale. Veniamo all’interpretazione: con ǧihād, infatti, i musulmani si riferiscono sia a una battaglia vera e propria che a una lotta interiore.
L’interpretazione
Esistono due tipi di ǧihād: il grande ǧihād e il piccolo ǧihād.
Il primo è uno sforzo interiore, ovvero la lotta con se stessi per vincere le passioni terrene e diventare uomini migliori. Per dirla in termini molto moderni si tratta di uno sforzo per la “crescita personale” (al- ǧihād al-akbār, cioè “lo sforzo maggiore”). Questo è il significato originario di ǧihād.
Il secondo, invece, è uno sforzo esteriore, in quanto fa riferimento alla guerra che, però, può avvenire solo in casi particolari (al- ǧihād al-aṣghār, cioè “lo sforzo minore”).
Queste sono le due interpretazioni più importanti e diffuse dall’VIII secolo circa grazie alle dottrine sufi.
Soffermiamoci un momento sul piccolo ǧihād.
Abbiamo visto il chiaro riferimento alla guerra,
ma dobbiamo tenere presente le diverse esegesi, molte delle quali ritengono che nel Corano non si parli di guerra offensiva, ma di difesa della comunità islamica.
ma dobbiamo tenere presente le diverse esegesi, molte delle quali ritengono che nel Corano non si parli di guerra offensiva, ma di difesa della comunità islamica.
Bausani, nel suo saggio “L’Islam” (Garzanti, 2002) chiarisce che l’obbligo di difendere la comunità islamica è affidato a tutti i credenti che possano usare un’arma, ma solo in caso di aggressione. Comunque non tutti gli studiosi concordano con la definizione di “guerra difensiva”.
Su quest’ultima teoria, come vedremo, esistono delle ulteriori sfumature di significato.
Dunque, in generale, ci troviamo di fronte a due diverse concezioni di ǧihād: una riguarda l’impegno, la fatica per avvicinarsi ad Allah, l’altra è una lotta nell’accezione più comune, su un campo di battaglia.
Nel Corano esistono riferimenti a entrambe le interpretazioni, ma per chiarire meglio il concetto di ǧihād è necessario analizzare il contesto storico in cui questo si formò.
Guerra santa?
Una cosa è certa: ǧihād non è traducibile con “guerra santa”. Sono due concetti diversi figli di contesti e idee altrettanto differenti. Non solo: come ci spiega Gabriele Mandel nel saggio “Islam” (Electa, 2006) al-ḥarb al-muqaddasa, ovvero “guerra santa” (الحرب المقدسة) non compare mai nel Corano; l’espressione venne usata, per la prima volta, in una predica di Pietro l’Eremita nel 1096, cioè all’inizio della prima Crociata.
Per i primi musulmani e per lo stesso Maometto fare la guerra significava scontrarsi con quanti erano ostili all’Islam e, soprattutto, con i politeisti che abitavano La Mecca. Questo è il contesto puramente storico in cui nacque la religione islamica e si rafforzò il “suo istinto di sopravvivenza”.
Guerra, dunque, era sinonimo di conquista, di sottomissione e di potere politico.
Ovviamente guidare una comunità voleva dire anche sviluppare una fondamentale inclinazione per la diplomazia, che consentì ai musulmani di promuovere la pace attraverso patti stipulati con ebrei e cristiani, ma anche con gli stessi meccani (ricordiamoci sempre di essere su una specie di “campo minato” in cui i termini possono risultare troppo stretti per accogliere sfumature di significato o, ancora più in grande, strategie politiche per cui conquiste e diplomazia non sono necessariamente antitetici; certo bisogna tenere conto del fatto che gli accordi, spesso, sono a vantaggio della parte più forte o vittoriosa e possono essere rotti, trasgrediti, dunque generare nuove battaglie in cui la pace e il patto vengono rinegoziati).
Frutto dell’arte diplomatica fu anche la dhimma, ovvero il particolare status concesso, tramite un accordo di protezione, dai musulmani alla “Gente del Libro” nei territori conquistati (ebrei e cristiani in un primo momento, ma tale status venne, in seguito, accordato anche ai fedeli di altre confessioni).
Rammentiamo, comunque, che stiamo parlando di accordi di natura politica, che mutarono nel tempo e, nel caso della dhimma, anche in base ai luoghi in cui vennero applicati e alle strategie diplomatiche dei sovrani in carica.
C’è, poi, un altro fatto di cui dobbiamo tenere conto quando parliamo di ǧihād e contesto storico: in quale momento avvennero le rivelazioni contenenti questo termine. Dove si trovava il Profeta, a La Mecca o a Medina?
Nelle sure meccane, secondo quanto spiegato da molti studiosi musulmani e non, il ǧihād rappresenta unicamente lo sforzo interiore. In quelle medinesi, invece, è più evidente il significato di lotta militare contro La Mecca associata a tale termine.
E’ chiaro, quindi, che il concetto di ǧihād ha bisogno, per essere spiegato, del riferimento al contesto storico in cui è nato.
Detto questo la definizione di “lotta difensiva” può essere e, di fatto, viene messa in discussione; combattere contro quelli che sono considerati infedeli, infatti, può giustificare l’attacco, presentato come una battaglia per “difendere” la sopravvivenza dell’Islam. Il Corano annovera tali lotte tra i dovere di ogni musulmano.
La Casa dell’Islam
Le prime conquiste islamiche avevano uno scopo ben preciso: l’espansione, che non presupponeva la conversione.
I primi musulmani, infatti, tenevano al carattere “arabo” della loro religione e la dhimma era più che sufficiente per regolare i rapporti di convivenza tra loro e i fedeli delle altre religioni.
Questo stato di cose, dato il livello espansionistico raggiunto e l’incontro con altri popoli e differenti usi, non durò a lungo. Lo sviluppo del diritto musulmano e della società islamica portò a scindere, in maniera netta e inequivocabile, il mondo allora conosciuto in due grandi “blocchi”: dar al-Islām e dar al-ḥarb, ovvero la “Casa dell’Islam” e la “Casa della Guerra”, la terra dei musulmani e la terra abitata dagli infedeli.
Questa separazione non marcava solo dei confini fisici e religiosi ma, in qualche modo, rendeva la parte di mondo non islamizzata una sorta di terra da conquistare e assoggettare, in cui compiere razzie e, nello stesso tempo, portare l’Islam.
Si usava pianificare almeno un ǧihād ogni anno e, in caso di concretizzazione e vittoria, i popoli conquistati avevano due possibilità: convertirsi, oppure essere fatti schiavi.
Come ci ricorda il teologo Hans Kung nel suo saggio “Islam” (Rizzoli, 2005), il concetto di ǧihād subì un progressivo declino durante la colonizzazione, per poi risorgere nel Novecento, radicalizzandosi a causa di nuove e più estreme interpretazioni coraniche.
Questa radicalizzazione ha consentito la nascita e l’inarrestabile ascesa di gruppi terroristici come al-Qa’ida, divenuto tristemente famoso dopo l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 o lo stesso Isis che miete vittime e orrore ogni giorno.
A questo punto ci chiediamo se sia possibile sconfiggere il terrorismo e in che modo.
A questo punto ci chiediamo se sia possibile sconfiggere il terrorismo e in che modo.
E’ solo un’utopia pensare che possa esistere un dialogo tra cristiani e musulmani moderati e che possiamo lottare insieme affinché né l’odio né la prevaricazione abbiano la meglio?
Conclusione
Dialogare è possibile, costruire la pace è necessario, ma bisogna tenere in considerazione alcuni elementi, presentati in maniera esauriente, magistrale da Hans Kung e che condivido: per estirpare alla radice la piaga del terrorismo occorre investire più risorse nell’istruzione, nelle società e questo vale tanto per il mondo islamico quanto per quello occidentale.
Del resto il terrorismo prospera dove ci sono guerre, ignoranza, povertà, violenza, situazioni estremamente disagiate, che non favoriscono il pieno sviluppo del diritto alla libertà in ogni sua declinazione.
L’educazione, poi, si fonde con le altrettanto necessarie interpretazioni del Corano, le quali devono tenere conto del contesto storico in cui il messaggio divino è stato rivelato. C’è bisogno assoluto di riflessione e di critica, del dinamismo intellettuale che l’Islam, storicamente, conosce bene ed è l’esatto opposto della rigida, dogmatica accettazione perpetrata dagli estremisti.
Lo sforzo interiore e anche quello esteriore, dal momento che, come abbiamo già detto, esso va contestualizzato nel periodo storico di riferimento, non devono essere un punto di partenza, una legittimazione o una giustificazione per chi vuole diventare un “martire”, un kamikaze, un assassino, per chi cova odio e vuole solo spargimento di sangue o manipolare gli altri per secondi fini.
Al contrario; questo sforzo interiore è miglioramento di sé che nulla ha a che vedere con la distruzione e l'autodistruzione.
Da un punto di vista strettamente religioso, poi, il teologo evidenzia che secondo la fede islamica (e non solo, per chi crede) unicamente Dio può decidere della vita e della morte.
Il terrorismo fa paura, ma non possiamo e non dobbiamo lasciarci vincere. E' il momento, per musulmani e non, di svegliarsi.
Al contrario; questo sforzo interiore è miglioramento di sé che nulla ha a che vedere con la distruzione e l'autodistruzione.
Da un punto di vista strettamente religioso, poi, il teologo evidenzia che secondo la fede islamica (e non solo, per chi crede) unicamente Dio può decidere della vita e della morte.
Il terrorismo fa paura, ma non possiamo e non dobbiamo lasciarci vincere. E' il momento, per musulmani e non, di svegliarsi.
Bibliografia
Bausani Alessandro, L’Islam, Garzanti, Milano 2002.
Mandel Gabriele, Islam, Mondadori Electa, Milano 2006.
Kung Hans, Islam, Rizzoli, Milano 2005.
Cook David, Storia del jihad. Da Maometto ai giorni nostri, Einaudi, Torino 2007.
Scarcia Amoretti Biancamaria, Tolleranza e guerra santa nell’Islam, Sansoni Scuola aperta, Firenze 1974.
Fonte immagini: Ansa e Wikipedia (La presa di Gerusalemme durante la prima Crociata; l'Arcangelo Gabriele rivela il messaggio divino a Maometto)
Fonte immagini: Ansa e Wikipedia (La presa di Gerusalemme durante la prima Crociata; l'Arcangelo Gabriele rivela il messaggio divino a Maometto)